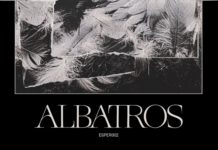Ok. Lo abbiamo visto tutti. O quasi. Per cui se non lo avete ancora visto non leggete perché ci saranno vari spoiler. Avviso fatto. Procediamo.
Charlie Brooker e Annabel Jones, anche se tutti parlano solo di Brooker, ci hanno abituato allo sgomento. Con Black Mirror hanno attualizzato ‘Ai confini della realtà’ ai tempi complessi che stiamo vivendo, restituendoci in forma di telefilm tutte le malefatte che ci stiamo facendo, soprattutto nel nostro rapporto con la tecnologia. In fondo hanno giocato facile in questi tempi di difficoltà di adattamento al futuro/presente, ma lo hanno fatto bene e ci hanno dato elementi nuovi per capire chi siamo e dove possiamo andare a parare se non cambiamo rotta. I due si erano allenati da tempo per questo. Nella sua carriera Jones ha gestito quasi sempre progetti al confine ed è quindi abituata a controllare e modellare il disagio e lo stress. Brooker è partito dalla satira e dai videogiochi per cui la capacità narrativa è sempre stata il nemico da affrontare, come il dj che non solo deve lavorare sulla scelta dei brani, ma soprattutto sulla loro sequenza, gestendo al meglio i climax e le attese. Perché alla fine è tutto lì. E’ questo che ci tiene legati ad uno schermo o a un dancefloor. Se non lo fai bene resta l’amaro in bocca e te ne vai dal locale o cambi canale.
In Bandersnatch quest’ultima possibilità viene messa al centro e possiamo scegliere (apparentemente) svariate linee narrative (in realtà cinque). Alcune sono meravigliose come il finale in cui Stefan si ricongiunge alla madre in un sacrificio d’amore fra Fai bei sogni di Bellocchio e Source code di Duncan Jones. Altre più scontate come l’idea di uccidere il padre/genitore per essere liberi (sempre Bellocchio, ma in salsa Tarantino). Altre semplicemente autoironiche come far apparire Netflix come incarnazione della produzione cinematografica da puro entertainment odierna (pure nichilista o violenta che, oggi come oggi, non va mai male). Ma questi sono abbozzi di critica perché non sono un critico televisivo o cinematografico e non ho studiato semiotica, nonostante sarebbe stato bello (ma per come sono fatto, meglio così… non ne sarei uscito più). Se volete delle belle critiche o comunque articoli molto interessanti su Bandersnatch, eccone alcuni:
Eugenia Fattori per www.seriangolo.it. Il migliore. Fatto da chi capisce i meccanismi della narrazione e non si esalta, ma sa anche che il mondo della narrativa oggi va a braccetto con quello dello stupore e ne parla con il giusto distacco pur apprezzando l’idea.
Brian Tallerico per www.vulture.com. Una raccolta di easter eggs che nella sua apparente nerditudine ci rivela invece la natura autoreferenziale divertita, quasi ironica, del progetto.
Lorenzo Ceccotti per il suo blog https://brataccas.blogspot.com. Non c’entra nulla con il prodotto televisivo, ma è una dettagliata storia, scritta da Lorenzo nel 2010 (si, nel 2010…) del vero videogioco Banderstanch della Imagine Software di Liverpool, realizzato fra il 1983 ed il 1984 e cioè nel periodo esatto dell’episodio di Black Mirror.
Lorenzo Fantoni per www.n3rdcore.it. In pratica una recensione a bivi che supera Broker e Jones in quarta e li spernacchia senza remore in quanto a complessità e velocità di esecuzione. Geniale e realizzata da uno che di videogiochi ne sa molto e bene.
Quello di cui invece vi vorrei parlare è della musica in Bandersnatch e della sua sostanziale inutilità. Lo capiamo a nostre spese quasi subito. Dopo l’inutile scelta fra cereali (ok, come si fa a non scegliere i Kellog’s…), la nostra prima scelta seria, quella che fa venire il brivido a chi ama la musica e ha vissuto quegli anni, è fra questi due album in cassetta: NOW That’s what I call music vol. II e Into the gap dei Thompson Twins.
Ora parliamone. Sei Charlie Brooker e fai il fico piazzando playlist ultra cool su Spotify, facendo capire che capisci di musica (anche quella dei ‘giovani’), ma in fondo sei del 1971 e nel 1984 avevi 13 anni cioè l’età in cui sei come una spugna e vivi tutto a mille. Ora: hai la possibilità di fotografare quel periodo e li rappresenti con due album che, chi viveva in quegli anni, sapeva che sarebbero diventati già dei classici da cesta a cinque euro? Non capisco e quindi parliamone.
NOW That’s what I call music vol. II
E’ la versione in cassetta di questa compilation baracca anni ’80 che conteneva brani di 30 artisti fra cui classici del rock inglese di alto livello come David Bowie, Queen, Rolling Stones e Paul McCartney, nuovi riferimenti del pop anni ’80 come Matt Bianco, Nik Kershaw, Culture Club o Howard Jones e esponenti più conosciuti della new wave come Duran Duran ed Eurythmics. Ed è proprio la meravigliosa Here comes the rain again degli Eurythmics che appare magicamente nelle cuffie del walkman (si ok, non so se lo conoscete tutti) di Stefan.
In realtà la versione in cassetta di questa compilation era composta da due cassette per via della durata del nastro e quindi questo pezzo era il secondo del lato A della seconda cassetta. Il primo era Relax dei Frankie goes to Hollywood che apre (giustamente) l’episodio (illudendoci). Ora quindi come faccia a suonare direttamente è una licenza tecnica piuttosto specifica, ma forse Stefan aveva già sentito Relax prima (vabbè lo so, è una cazzata, ma se hai mai avuto un walkman mi capisci).
A livello di mood il pezzo degli Eurythmics ci sta tutto, soprattutto quando il bus passa vicino al poster hackerato con il glifo di Pax e la scritta ‘No future’ e allora speri lo abbia fatto per convogliare il nichilismo post punk nella nuova carne new wave malinconica sognante. Ma a mentre fredda ti rendi conto che molto probabilmente Brooker e Jones non la intendevano così…anzi sicuramente! Ma tornando a noi. Perché prendere questo specifico brano da questa specifica inutile compilation e non direttamente dall’album di cui fa parte ovvero Touch, un album uscito nel 1983, ma incredibilmente significativo per quegli anni assieme a Sweet dreams dell’album successivo, sempre degli Eurhytmics?
Inoltre: perché dovrei scegliere questa compilation senza sapere quale pezzo verrà preso con la possibilità di trovarmi fra capo e collo i Flying Pickets con la loro versione di merda del capolavoro electroromantic degli Yazoo Only you? E allora ti viene spontaneo scegliere i Thompson Twins.
I Thompson Twins sono stati una delle classiche meteore new wave anni ’80. Facevano parte di quei gruppi inglesi che hanno funzionato solo quando rendevano in musica le loro canzoni con gli strumenti elettronici dell’epoca. Sempre al confine fra pop tribaltropicale e disagio funk bianco da periferia UK, il gruppo di Sheffield trapiantato a Londra erano dei Talking Heads più rozzi con batteristi fuori tempo e la consapevolezza che senza hit avrebbero finito presto la benzina.
E allora tirano fuori In the name of love e Love on your side che, grazie a dei remix stellari, li lanciano sui dancefloor di mezzo mondo e nell’immaginario di tanti ragazze/i di quegli anni. Ma questo fino al 1983.
Into the gap del 1984 è forse l’album più kitsch del gruppo con canzoni da Zecchino d’Oro come You take me up o da Riccardo Fogli in versione Brian Ferry come Doctor! Doctor! e con un uso dell’elettronica tipico di chi non capisce nulla di elettronica e usa quello che passa il mercato (e il mercato nel 1984 di robaccia elettronica ne iniziava a fornire a vagonate sostituendo i VCO con i PCM). Ok ci stava Hold me now che piace tanto a due miei amici e che si eleva nella media dell’album, ma non basta a ergerlo a scelta binaria in un telefilm narrativamente rivoluzionario.
Fra l’altro questo album è stato l’ultimo di successo del gruppo che poi si è perso nei sampler e in brani come Don’t mess with Doctor Dream, uno strano ibrido di funk digitale percussivo con un ritornello che neanche Life is life o l’imbarazzante Lay your hands on me, una specie di Bonnie Tyler su cascate indecenti di PCM. Quindi perché scegliere proprio i Thompson Twins in una storia di disagio e disordine mentale ambientata negli anni ‘80? E gli Ultravox? E John Foxx? L’affronto è altissimo.
Per cui scegli una delle due cassette e vai avanti. Fai errori o incontri finali strani e allora riparti e ti rendi conto che sostanzialmente non cambia nulla. Ti struggi dentro e senti montare la delusione che neanche il demone PAX o la distruzione di tuo padre a pezzi potrà placare. E’ l’inizio del disagio. Ma non di Stefan. Il tuo.
Ma andiamo avanti.
Il nostro problematico Stefan conosce il suo idolo, Colin Ritman, paranoide programmatore isolazionista e isolato, che dall’alto della sua sicurezza complottista lo indirizza verso la giusta musica per entrare nel mood di programmazione (il ‘buco’ come lo chiama Colin) per questo suo complesso progetto. Gli dà un foglietto con alcuni nomi di gruppi che Stefan, da buon fan devoto anni ‘80 cerca ovviamente in un negozio di dischi (prima di entrare si sente per pochi secondi Too shy dei Kajagoogoo – altra giusta e illusoria scelta).
La lista si vede per pochi secondi per intero, ma ciò che c’è scritto è quanto segue:
NON
The Glove
Tangerine Dream
The Cure
Bauhaus
Tomita
Edgar Froese
Joy Division
The Birthday Party
Anche in questo caso parliamone.
Prima di tutto che un programmatore complottista fissato con Huxley e Dick possa amare (o perlomeno consigliare) questi gruppi sarebbe tutto da dimostrare (Huxley e Dick erano poi dei maniaci della musica classica). E poi i NON e con un loro album completamente noise, Physical evidence, l’unico direttamente consigliato da Colin, gli altri sono nomi di band o artisti? Forse il rock elettro lisergico dei The Glove (un progetto fra Robert Smith dei The Cure e Steven Severin dei Siouxsie & The Banshees che ha generato un solo album) avrebbe funzionato alla grande sulle scene di programmazione di Stefan (Like an animal ci sarebbe stata alla grande), ma musicalmente sarebbe stato veramente fuori posto. E qui veniamo ad uno dei punti centrali di quest’analisi.
La musica nei videogiochi nasceva dall’utilizzo di funzioni limitatissime delle schede audio degli inizi degli anni ’80.
Dalle prime versioni giapponesi dei videogiochi da fine anni ’70 era chiaro che questa scelta imposta da limitazioni tecniche, aveva però definito un linguaggio specifico, originale e innovativo. Un mondo sonoro a sé che partendo da rielaborazioni di elementi della musica classica e della musica popolare (funk, folk, reggae e mille altre cose semplici e circolari) arrivava a gestire in maniera naturale le capacità ricettive di migliaia di ragazzi nel mondo fino a modificarne i gusti musicali.
L’arrivo di tecnologia a basso costo nel mondo degli strumenti musicali fece defluire queste mutate condizioni di ascolto dentro canali nuovi che si chiamavano sintetizzatori, batterie elettroniche e successivamente campionatori, creando nuovi generi come l’electro, la new wave, l’EBM e successivamente l’house, la techno e la drum ‘n bass.
Non analizzare questo passaggio nel 1984 è un grave errore del duo creativo di Black Mirror che invece è molto attento su altri dettagli iconografici e architettonici di quel periodo a livello produttivo (l’ambientazione, la scenografia, la fotografia sono come al solito quasi perfette). E allora l’affronto diventa consapevolezza: al duo Brooker/Jones della musica di quegli anni interessa solo la superficie.
Non c’è il disagio elettronico o la speranza malinconica che permeava quel periodo, il ‘dancing with tears in my eyes’ è sfiorato. Forse per non offuscare il resto? E’ stato troppo potente quel periodo a livello musicale in termini di cambiamento da non essere ancora stato assimilato? Perché non leggere Morley oltre Debord?
Ma andiamo avanti. Per fortuna da quella lista vengono scelti solo Phaedra dei Tangerine Dream e The Bermuda Triangle di Isao Tomita. In questo caso il colpo al cuore è potentissimo per cui analizziamo.
E’ il quinto album del gruppo tedesco che fa proprio dell’epica meditativa la sua caratteristica primaria. Abbandonati gli strumenti classici dei primi album, dal 1970 al 1973, “Phaedra” è il primo album del gruppo che mette al centro del loro suono i soli sintetizzatori (eccetto qualche organo sparso verso la fine), accantonando improvvisazioni di matrice progressive rock ed ogni forma di ritmica acustica. Il ritmo diventa invece quello pulsante dei sequencer e degli arpeggiatori e delinea la strada per mille altri progetti musicali degli anni a venire che si rifaranno all’album come vero e proprio manuale della trance elettronica in senso lato. Inoltre, fattore non da poco, l’album uscì su Virgin il cui logo in quegli anni era stato disegnato da Roger Dean, storico illustratore inglese che aveva realizzato loghi di band storiche come gli Yes e cover di album di gruppi come gli stessi Yes (forse le più famose) e Uriah Heep. Ma Dean ha anche illustrato le cover dei videogiochi della Imagine, divenuta poi Psygnosis, la stessa casa di produzione inglese che realizzò il vero videogioco Bandersnatch. Citazione casuale? Speriamo di no. Se lo fosse sarebbe l’unico vero colpo di coda del suo creativo di Black Mirror. Comunque “Phaedra” è l’unico album che ho dei Tangerine Dream perché è l’unico che tiene a bada i barocchismi di Froese & C. e quindi vederlo lì, e sapendo cosa voleva dire in termini di meditazione e concentrazione, mi sembrava la scelta perfetta per programmare. E quindi l’ho scelto e, devo dire, era perfetto. Un vero momento di sincronia emotiva fra video e sonoro che, per quanto mi riguarda è fondamentale quando vedo qualsiasi forma di film o telefilm/serie che sia. Ma resta la domanda: Perché un giovanissimo come Colin dovrebbe consigliare a livello elettronico questo album del 1974 per rappresentare quegli anni? E qui veniamo all’altra scelta/bivio a cui andiamo incontro.
Isao Tomita “The Bermuda Triangle”
Che Isao Tomita sia un genio è fuori di dubbio, ma che sia anche un po’ il Liberace dell’elettronica sinfonica è anche una dato di fatto. Non tanto a livello caratteriale (Tomita era esattamente l’opposto dell’eccentrico pianista USA), ma perché, con la maestosità a volte pacchiana dei suoi arrangiamenti sinfonico elettronici, riuscì a rendere popolare al grande pubblico degli anni ‘70/’80 la musica classica, come l’eccentrico pianista USA fece negli anni ‘50/’60 (Bill Meyers lo fece con il jazz sempre negli anni ’80 con risultati altissimi, ma è tutto un altro discorso). Praticamente Tomita ha colto al balzo la sfida di Wendy Carlos e l’ha messa ko. “The Bermuda Triangle” è un altro tassello nella sua rielaborazione elettronica della musica classica con brani di Prokofieff, Sibelius e una riedizione in salsa theremin anni ’50 del tema di “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di John Williams. Dal punto del principio ci starebbe sia per l’amore dei mentori di Colin (Huxley e Dick) per la musica classica, sia per le sonorità sintetiche, molto simili a quelle presenti nei videogiochi di quegli anni, ma se la scegli e vedi Stefan programmarci, ti rendi conto che non c’entra assolutamente nulla. Però c’è un dettaglio non da poco riguardo questo album. Sui solchi del vinile erano presenti dei codici che se interfacciati con uno ZX Spectrum (storico computer di quegli anni), tiravano fuori a schermo interessanti (e infondate) info sul triangolo delle Bermuda. Erano anni in cui il libro di Charles Berlitz sul Triangolo delle Bermuda era in tutte le case che neanche il Reader’s Digest (ah i bei tempi dell’ingenuità complottara!) per cui ci sta tutto, ma anche in Bandersnatch ci sono dei codici che, se fatti leggere sempre da uno Spectrum, ti danno la possibilità di andare su un sito finto della Tuckersoft, la casa di produzione che doveva produrre il videogioco di Stefan, e di giocare con alcuni giochi. E’ tutto spiegato qui .
Qui invece trovate tutte le info sui codici nell’album di Tomita e di tanti altri gruppi che hanno fatto la stessa cosa in quegli anni.
Brooker sapeva di questa cosa? Lo ha fatto apposta? Forse si, visto il suo livello di nerdaggine su questi dettagli, ma resta il fatto che la musica di Tomita non funziona con le immagini come invece avviene con quella dei Tangerine Dream e che, SOPRATTUTTO, la scelta di una musica o dell’altra NON influisce sullo svolgimento della storia, se non in termini di narrazione (forse era chiedere troppo), almeno a livello di mood. In sostanza la musica in Bandersnatch ha lo stesso valore di un pacco di cereali.
Ora qualcuno dirà che in generale la musica nelle produzioni cinematografiche e televisive è solo uno strumento di decorazione narrativa, magari importante come la scelta delle luci o delle scenografie, ma pur sempre NON determinante, ma, amiche e amici che finora mi avete seguito in questo delirio, la situazione in questo caso mi sembra chiara e, con le prove sopra riportate, accuso Brooker e Jones di alto tradimento musicale verso quegli anni. Oppure di aver messo in secondo piano la musica, proprio come quei proprietari di locali che fanno cessi da paura e poi con i soldi avanzati fanno l’impianto. E non si tratta di nerdismo musicale da vecchio umarells, perché il duo ha speso mesi per mettere su in piedi questo progetto seguendo in maniera maniacale invece citazioni autoreferenziali (le trovate nell’articolo di Vulture di cui sopra), dettagli molto precisi sul mondo dei videogiochi di quegli anni e affrontando problemi logistici e di stesura del girato non facili (in questo articolo di Wired UK si capisce la complessità della realizzazione del film interattivo).
Ma è colpa loro? E’ solo una scelta produttiva casuale? O rientra tutto in una tendenza precisa di questi anni postmoderni in cui le nuove idee sono rare come un’aragosta blu e conta troppo spesso più la forma del contenuto o anche la sua ‘notiziabilità’ (bellissimo neologismo usato da Fattori nel suo articolo citato sopra)? Non è che abbiamo finito di stupirci e ci accontentiamo di come veniamo stupiti? Non è questo un segnale di quello che io chiamo ‘famolostranismo’ ovvero la corsa al colpo ad effetto che si bea di sé stesso e accarezza (solo) la nostra razionalità? Non ho gli strumenti semiotici per dare risposte a livello di critica cinematografica c’è chi cerca di farlo da un po’ e magari ci ragionerà ancora, ma, tornando in campo musicale in cui gioco meglio, vedo dei parallelismi.
Il colpo ad effetto narrativo altri non è che il drop, il vero protagonista della musica contemporanea, l’annullatore della strofa, l’evoluzione coatta del clash con il futuro che la musica da metà anni ’80 in poi ci aveva riversato nelle orecchie cambiando il nostro sentire, ma (sembra) non il nostro capire, in un processo di sound overload purtroppo inarrestabile, ora che il futuro è diventato il nostro presente. Il casaccismo modulare è solo la cartina al tornasole della difficoltà di gestire questa marea di suono che ci circonda e siamo speso costretti a dare un significato a cose che non ne hanno per giustificarlo (come avviene con gli Autechre ad esempio).
E’ come un sogno da cui ci siamo svegliati, circondati da cloni di quei suoni di cui si sono perse le radici, liquefatti nel cyberspazio, ormai divenuto a volte salotto gilettiano, a volte assemblea da collettivo, a volte luogo di lapidazione e scontro virtuale e troppo poco luogo di aggregazione (possibilmente) rivoluzionaria. Questi suoni, sempre più liquidi, vengono presi come da uno streaming ininterrotto e gettati troppo spesso nell’arena della ‘nuova carne’ come condimento necessario, ma con troppo poco rispetto. E quindi, cullato dall’ultima sezione di “Phaedra”, quella più sinfonico melodica, mi avvio verso un finale epico catartico, senza senso apparente e con tanti dubbi come Tim Robbins che sale le scale inondate di luce nel finale di “Allucinazione perversa”, sperando (come sempre) in progetti futuri in cui la musica sia maggiormente considerata come linguaggio unico e universale di pura trasmissione di emozioni. Come accade a Natalie Portman quando incontra l’alieno sonoro liquido che non sarebbe tale senza la musica di Moderat e che spiega il senso del film molto più di mille parole. O come fa praticamente ogni volta Terrence Malick o Francis Ford Coppola.
Vado a sentire Laurie Anderson e la sua ode a Superman sperando di svegliarmi migliore, come avrei augurato a Stefan dopo aver accompagnato (finalmente) la madre ed aver espiato la sua non colpa.
Andrea Benedetti